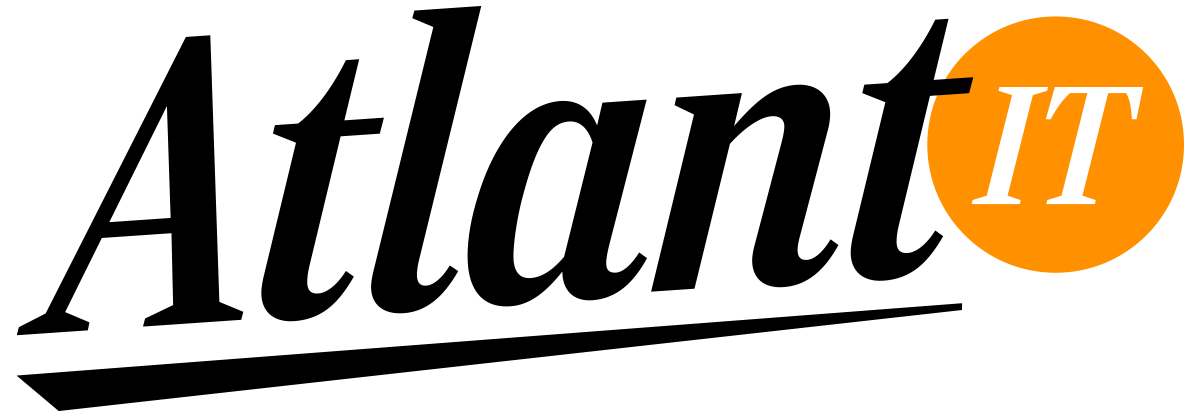Da semplice viaggiatore a voce italiana su New York: Tony Like a Local è diventato in pochi mesi un punto di riferimento per chi cerca qualcosa in più oltre alla Statua della Libertà e Times Square. Lo fa con un approccio intimo e curioso, mostrando quella “New York da terza volta” che spesso si scopre solo dopo essersi lasciati alle spalle l’incanto turistico. L’abbiamo intervistato per farci raccontare la nascita del progetto, l’amore per la città e i suoi angoli nascosti.
Partiamo dall’inizio. Poco più di un anno fa hai deciso di aprire una pagina su New York, in un momento in cui già tante persone facevano qualcosa di simile. Come mai l’hai fatto?
L’amore per New York è stato sicuramente il motivo principale. Però non mi bastava tenermelo per me, venirci in vacanza e basta. Avevo proprio bisogno di parlarne, ma avevo anche esaurito la pazienza di mia moglie e dei miei amici: dovevo trovare uno sfogo diverso. All’inizio volevo fare video su YouTube, qualcosa di più strutturato e lungo, ma è molto più complesso: richiede tempo, energia, costanza… e io non vivo a New York. Così ho scelto Instagram, che ti permette di raggiungere più persone in meno tempo. Ho cominciato a raccontare la città, ma da un punto di vista diverso rispetto a chi fa contenuti più turistici. Il mio profilo è pensato per chi viene qui dalla seconda, terza volta in poi. Chi ha già visto la Freedom Tower, l’Empire, il Top of the Rock, e vuole scoprire un lato più cittadino, più local. Il nome stesso, “Tony Like a Local”, nasce da lì: una coincidenza con il mio nome e con il tipo di approccio.
Da quanti anni vieni a New York e com’è nato il tuo rapporto con la città?
Dal 2017. Ci sono venuto con mia moglie per il viaggio di nozze, a Natale. È stato magico: il 24 sera, mentre andavamo a cena, ha iniziato a nevicare. Una scena da film. Ce ne siamo innamorati e ci siamo detti: “Torniamoci ogni anno, per periodi sempre più lunghi”. E così è stato, a parte lo stop forzato del Covid. Dopo quei due anni fermi, siamo tornati per un mese intero: nostra figlia aveva appena compiuto un anno e abbiamo anche il video dei suoi primi passi sul ponte di Brooklyn. È come se il destino avesse deciso per noi. Poi, vivendo anche a Brooklyn, abbiamo scoperto una New York più calma, più di quartiere. La gente ci riconosce, gioca con Alice, ci offre il pane di Sant’Antonio… è un senso di comunità che, anche se diverso, somiglia a quello italiano. Solo che qui è ancora più piccolo, più intimo.
C’è una ricerca che dice che gli italiani, potendo scegliere un solo viaggio nella vita, sceglierebbero New York. Più di qualunque altra popolazione. Perché secondo te?
Perché abbiamo vissuto New York anche senza esserci mai stati. È vero che il cinema americano è globale, ma noi italiani siamo stati inzuppati nella cultura pop americana in modo particolare: pensiamo agli anni ’80, al boom economico, a Jovanotti, ai Levi’s, alle serie TV. Le serie ti fanno affezionare ai personaggi e ai luoghi: quando arrivi a New York, ti sembra di conoscerla già. Il cervello non distingue tra esperienza reale e vissuto mediato da un libro, un film, un racconto. Io sono sempre stato un americanista, leggevo romanzi americani, saggi, guardavo serie… in un certo senso ci ero già stato, senza esserci mai stato davvero.
E quindi quando ci arrivi, la vivi due volte.
Esatto. C’è questa sensazione di déjà vu, che non succede in altre città. Forse un po’ a Roma, che abbiamo molto interiorizzato anche cinematograficamente, ma mai come con New York. È compatta, riconoscibile, vivibile a piedi. E poi c’è questo amore-odio tipicamente italiano per l’America: la idealizziamo e la critichiamo allo stesso tempo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci ammiri, e sapere che “gli americani ci adorano” ci fa sentire ancora importanti, anche se magari non è sempre vero. Mia madre non è mai stata in America, ma è convinta che gli americani adorino gli italiani. Forse è anche questo a renderci così legati a New York.
Hai mai fatto arrabbiare qualcuno che vive qui e fa un lavoro simile al tuo?
No, anzi. Quelli che c’erano già prima di me sono stati molto accoglienti. Alcuni li ho conosciuti, con altri ho collaborato. Nessuna invidia, o almeno, se c’era, non me l’hanno fatta notare. C’è un bel senso di community. Cerco sempre di evitare le polemiche, non polarizzo mai l’attenzione. Racconto storie, non do opinioni. Forse questo aiuta.
Non vendi viaggi, tour, itinerari… Hai intenzione di restare così o stai pensando a un’evoluzione del progetto?
Non voglio vendere itinerari, no. Però ho un progetto più ampio che riguarda sempre la comunicazione video: l’idea è fare una serie su YouTube, a puntate, più stagioni, sei episodi a stagione, pubblicati ogni due settimane. Vorrei raccontare storie di New York in modo più approfondito, magari con episodi da 40-45 minuti. E per finanziare il progetto, penso a collaborazioni con brand che credano nell’idea. Non voglio vendere pacchetti vacanza, voglio raccontare la città.
A proposito di raccontare: se dovessi indicare tre posti poco noti che ti piacciono molto, anche per chi vive qui da anni?
Il primo è un cortile nascosto vicino a Washington Square Park: si chiama Vanderbilt Hall, fa parte della NYU. È minuscolo, silenzioso, con tavolini, panchine, una piccola cascata. Non ci va quasi nessuno, nemmeno gli studenti: ci passi solo se sai che c’è.
Poi adoro i bar come li intendono qui: ti siedi al bancone, parli con il bartender, con il vicino. Ogni volta scopri storie incredibili. L’altro giorno, vicino Times Square, ho conosciuto un signore che da 36 anni gira l’America in auto per vendere vino. Lavorava per un’azienda vinicola dell’Ohio… chi avrebbe mai pensato che ci fosse una vinicola in Ohio?
Il terzo è il concetto di playground. In Italia spesso sono trascurati, pieni di adolescenti, pericolosi. Qui sono puliti, chiusi con cancelli, accessibili solo ai bambini accompagnati. Mia figlia ci gioca libera e sicura. Questo dà un senso di libertà anche a noi genitori. E si vede: i bambini qui crescono più sicuri, più autonomi.
Hai mai pensato di trasferirti qui definitivamente?
No. Mi piace viverla così: venire spesso, anche per mesi, ma senza stabilirmi. In questo modo mi prendo solo i vantaggi, senza gli aspetti negativi — stress, scuola costosa per mia figlia, eccetera. Lei ormai è abituata a venire spesso… magari un giorno vorrà studiare qui. A quel punto, chissà.
Che impatto ha avuto il progetto sulla tua azienda?
Dal punto di vista tecnico, nessuno. Ma psicologicamente mi ha aiutato tantissimo. Ero arrivato a un punto di saturazione con l’azienda: funzionava bene, avevo un team rodato… ma non c’era più adrenalina. Questo progetto mi ha dato una nuova energia, un nuovo giocattolo da far crescere. Mi rilassa. Non ha portato nuovi clienti, ma mi ha reso più sereno nel gestire tutto il resto.
C’è qualcosa che non abbiamo detto e che vuoi aggiungere?
Spesso mi chiedono come faccio a sapere tutte queste cose. La risposta è semplice: leggo tanto, romanzi, saggi, articoli. E sono curioso. E poi mi butto nei posti a caso: un locale, un ristorante, un bar che da fuori ha quell’atmosfera newyorkese. A volte scopri delle perle incredibili, altre volte delle ciofeche. Ma il bello è proprio quello.
L’articolo Tony Like a Local racconta New York oltre i soliti luoghi proviene da IlNewyorkese.