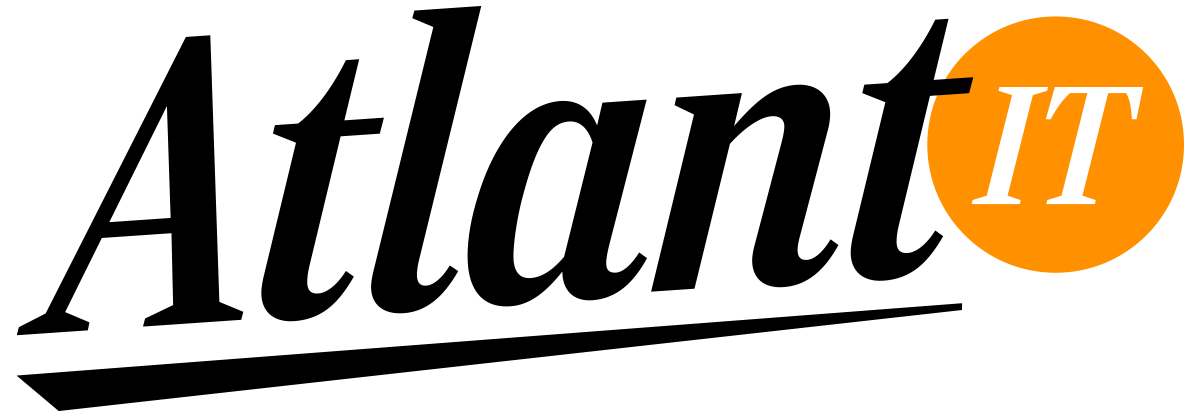L’endofasia, o voce interiore, si modifica drasticamente a seguito di un’esperienza di violenza, passando dall’auto-riflessione ad una forma di silenzio o di autocensura, dalla quale è difficile riemergere. Come trasfigurare questa voce, che rischia di rimanere segregata nel dolore, in una narrazione di rivalsa che possa diventare testimonianza letteraria? Come fare della propria esperienza un racconto capace di fornire spazi di riflessione e di educazione per altre vittime, senza cadere nella trappola dell’enfasi morbosa sul carnefice, ma centrando il discorso sulla ricostruzione e sulla liberazione emotiva?
Quando una persona subisce un trauma devastante come lo stupro, l’endofasia — la voce interiore — diventa un luogo di contesa. La mente che prima era capace di riflessione, di comprensione e di comprensione di sé stessa, si trova a dover fare i conti con un’esperienza che risulta talmente travolgente da non riuscire più a trovare parole adeguate per esprimerla. L’endofasia si trasforma in un silenzio assordante, un muto grido di disperazione che imprigiona la mente nella solitudine più totale del dolore. È come se il linguaggio non fosse più sufficiente a contenere l’intensità della sofferenza. Questo, in modo particolare, è un tema che affronto nel mio ultimo libro, “Di un’altra voce sarà la paura”, dove esploro le dinamiche della violenza psicologica e la sua connessione con altre forme di trauma, come quello da stupro. La violenza psicologica, sebbene spesso invisibile, è un tipo di abuso che lascia ferite altrettanto profonde, e per molto tempo può sembrare che non ci sia modo di articolare e dare voce a un dolore che resta intrappolato nella mente, incapace di manifestarsi in modo chiaro.
Nel mio libro, il silenzio della vittima è uno dei temi principali, e parlo di come questo silenzio non sia mai davvero vuoto. Esso è il risultato di un trauma profondo, che intacca l’essenza stessa della persona. Chi ha vissuto la violenza, come nel caso dello stupro, si trova in una condizione in cui la propria voce interiore è mutilata, spezzata. La mente e il corpo sembrano non riuscire più a trovare il modo di comunicare il proprio vissuto. Il trauma distrugge non solo il corpo, ma anche la capacità di riflettere su di esso. L’individuo si ritrova a convivere con una ferita invisibile, spesso senza nemmeno il coraggio di affrontarla o nominarla, e questo silenzio diventa l’espressione del dolore non elaborato. Questa incapacità di trovare parole per esprimere il trauma è centrale nel mio racconto. Il silenzio diventa una reazione difensiva, una barriera che il corpo e la mente erigono per proteggersi dall’intensità del ricordo. Ma questo silenzio non è pacifico, è invece il teatro della contesa interiore. Da un lato c’è la necessità di esprimersi, di raccontare la propria storia, e dall’altro c’è la paura di non essere creduti, di essere giudicati o, peggio ancora, di non riuscire a trovare le parole giuste per restituire dignità a un’esperienza tanto umiliante e distruttiva. In questo senso, la violenza psicologica e quella fisica si intersecano, perché entrambe sottraggono alla vittima la possibilità di una narrazione propria, che non sia macchiata dal controllo o dalla manipolazione.
Ho scelto di chiamare il mio libro “Di un’altra voce sarà la paura” perché la paura è la forma che assume la voce interiore di chi è stato vittima. Non è una voce di rivendicazione, ma di rassegnazione, paura e solitudine. È la paura che spesso impedisce alla vittima di parlare, di chiedere aiuto, di esprimere il proprio dolore. Ma, al contempo, è anche la paura che, attraverso la scrittura, può essere trasformata in una nuova voce. Una voce che non è più quella della vittima silenziosa, ma quella di chi, finalmente, trova il coraggio di raccontare. Nel libro, ho cercato di mettere in relazione il silenzio con il trauma, perché ho osservato che troppo spesso il dolore delle vittime di stupro è relegato a un silenzio che neppure la vittima stessa riesce a infrangere. La scrittura è per me un mezzo per spezzare quel silenzio, per restituire una voce a chi non è mai riuscito a trovarla, o l’ha persa nel processo di distruzione del trauma. Nella violenza psicologica, la vittima spesso si sente invisibile, come se il proprio dolore fosse troppo intimo e insostenibile per essere raccontato. La scrittura, allora, diventa uno strumento di resistenza. Non è solo un atto catartico, ma un modo per restituire significato, dignità e identità alla vittima.
Nel mio lavoro, ho voluto dimostrare come sia possibile trasformare quel dolore e quel silenzio in una nuova forma di resistenza. La scrittura non è solo un modo per dare voce al dolore, ma anche per educare gli altri, per rompere il ciclo del silenzio che circonda la violenza, per dare a chi ha subito abusi una possibilità di ricostruire la propria narrativa. Per me, scrivere è stato un atto di riscatto. Scrivere è stato il mezzo attraverso cui ho potuto dare una forma alla paura, una forma che non fosse un muro, ma un ponte.
L’articolo Dalla sofferenza alla rivalsa attraverso la scrittura proviene da IlNewyorkese.