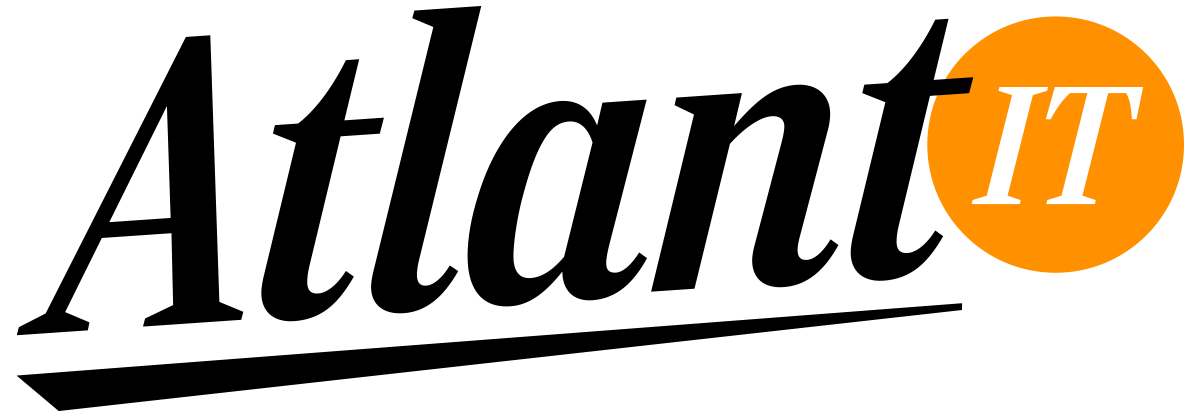Nel luglio del 2016, a Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, 33 persone finirono in ospedale nel giro di poche ore per l’assunzione di K2, la cosiddetta “marijuana sintetica”. La scena — corpi barcollanti, sguardi persi, malori in strada — spinse le autorità sanitarie cittadine a un avviso urgente. Non era un episodio isolato: da mesi New York stava inseguendo un fenomeno che si spostava tra minimarket di quartiere e rivendite improvvisate, con bustine vendute a pochi dollari. L’anno prima il sindaco Bill de Blasio aveva già firmato tre leggi per criminalizzare produzione e vendita delle miscele, inasprendo sanzioni e fornendo nuovi strumenti amministrativi per chiudere gli esercizi recidivi. Ma il mercato continuava a ripresentarsi con nomi e formule chimiche sempre diverse.
Per capire perché sia così difficile arginarlo bisogna guardare alla sostanza. Quello che viene chiamato “Spice” è materiale vegetale impregnato con cannabinoidi sintetici: molecole progettate in laboratorio che si legano ai recettori CB1 in modo molto più deciso del THC naturale. A differenza della cannabis, che agisce come agonista parziale, molti composti sintetici sono agonisti “pieni”: il risultato è una potenza elevata anche a dosi minime e un margine d’errore quasi nullo per chi li consuma. È una delle ragioni per cui le intossicazioni acute hanno un ventaglio di esiti severi — convulsioni, aritmie, psicosi — documentati da centri antidolo e agenzie di monitoraggio europee.
La storia nasce in ambito accademico: dagli anni Ottanta il chimico statunitense John W. Huffman e altri gruppi sintetizzarono centinaia di analoghi del THC per studiare il sistema endocannabinoide. Quelle strutture, pubbliche e replicabili, sono poi state “dirottate” verso il mercato ricreativo: piccoli cambi alla coda di una molecola bastano a creare un composto nuovo, difficile da intercettare dalle leggi scritte per elenchi chiusi. In questo inseguimento normativo i produttori hanno sfruttato anche gli espedienti dell’etichetta — diciture come “non per il consumo umano” sulle bustine — per spostare la responsabilità e guadagnare tempo.
L’Europa ha osservato con attenzione la comparsa di singoli composti particolarmente pericolosi. Nel 2016 l’EMCDDA sottopose a valutazione MDMB-CHMICA, un cannabinoide sintetico associato a decine di intossicazioni e morti in vari paesi: nei mesi successivi fu posto sotto controllo in tutta l’Unione. Quel caso rese evidente un punto: non si parla di un’unica “droga” ma di una famiglia in evoluzione, dove l’ingresso di una nuova molecola può cambiare rapidamente il profilo di rischio.
Negli ultimi anni le vie di esposizione si sono moltiplicate. In Inghilterra analisi su centinaia di sigarette elettroniche sequestrate nelle scuole hanno individuato cannabinoidi sintetici in circa una su sei; un articolo scientifico del 2025 descrive lo stesso fenomeno riscontrato in numerosi istituti secondari. È un dato che sposta l’attenzione dalla scena dello spaccio tradizionale alla presenza inconsapevole in prodotti di largo uso giovanile, complicando prevenzione e controlli.
In Italia, secondo la Relazione al Parlamento 2025 (dati 2024), l’uso di nuove sostanze psicoattive tra gli studenti è stimato al 5,8% nell’anno, con i cannabinoidi sintetici in calo dal 4,6% al 3,5% rispetto all’anno precedente. La cannabis resta di gran lunga la sostanza più diffusa, ma l’andamento delle NPS conferma che una quota non trascurabile di adolescenti incontra — talvolta senza saperlo — composti con profili tossicologici più severi e imprevedibili della cannabis stessa.
Negli Stati Uniti, dove emerse la crisi di Brooklyn, le autorità hanno affiancato ai divieti di singole molecole norme “a famiglia” e ripetuti avvisi di salute pubblica: mentre i divieti si allargavano, i produttori modificavano le formule e continuavano a commercializzarle come “incensi erboristici” o “pot-pourri”, spesso a basso costo e senza alcuna informazione sanitaria. È una dinamica nota anche ai centri antiveleni: la combinazione tra potenza elevata, variabilità di dosaggio e qualità scarsa rende l’effetto finale difficile da prevedere per chi consuma e per chi presta soccorso.
Il punto, allora, non è trattare lo Spice come una variante “debole” della cannabis, ma riconoscerne la logica industriale e regolatoria: si compra un nome commerciale, ma dentro c’è una chimica che cambia, talvolta molto più attiva del previsto. La lezione del 2016 a New York — una città che aveva già inasprito leggi e controlli — e i riscontri più recenti sulle e-cig sequestrate nel Regno Unito certificano la necessità di un’attenzione capillare nei confronti dei nuovi composti chimici che emergono.
L’articolo Cosa si sa dei cannabinoidi sintetici, la famiglia di droghe che cambia continuamente formula proviene da IlNewyorkese.